 In Italia è un’estate calda per Google. Il Garante della Privacy ha dato 18 mesi di tempo al gigante di Mountain View per rendere chiare e inequivocabili tutte le informative agli utenti. Chi accede ai vari servizi di Google deve sapere se il proprio profilo viene sfruttato a fini commerciali. In questo caso, l’utente deve dare un esplicito consenso e non finire a sua insaputa nella grande marmellata virtuale, in quel miscuglio in cui con un clic si diventa un “dato” buono per una molteplicità di piattaforme e per gli usi più disparati. Diventano più stringenti anche gli obblighi per la cancellazione degli account o dei dati personali, se un utente vuole recedere. Google si è detta pronta a collaborare e, in genere, una compagnia di quelle dimensioni mantiene la parola.
In Italia è un’estate calda per Google. Il Garante della Privacy ha dato 18 mesi di tempo al gigante di Mountain View per rendere chiare e inequivocabili tutte le informative agli utenti. Chi accede ai vari servizi di Google deve sapere se il proprio profilo viene sfruttato a fini commerciali. In questo caso, l’utente deve dare un esplicito consenso e non finire a sua insaputa nella grande marmellata virtuale, in quel miscuglio in cui con un clic si diventa un “dato” buono per una molteplicità di piattaforme e per gli usi più disparati. Diventano più stringenti anche gli obblighi per la cancellazione degli account o dei dati personali, se un utente vuole recedere. Google si è detta pronta a collaborare e, in genere, una compagnia di quelle dimensioni mantiene la parola.
Perché la notizia dell’intervento del Garante italiano è una buona notizia? Google non è soltanto il più cliccato e “amichevole” motore di ricerca al mondo. Non ci offre, soltanto, traduzioni in tempo reale. E’ un colossale sistema informatico, fondato nel 1998 da Larry Page e Sergey Brin in California, che incamera e genera dati e servizi di ogni tipo, un colosso tanto affidabile quanto, in più occasioni, discusso, soprattutto quando lo si è accusato di essere troppo tenero con i servizi segreti e con i governi che praticano la censura. Dentro Google ci sono news, blog, mappe, posta elettronica, analisi statistiche, pagamenti online, video, foto, libri, shopping e backup di archiviazione. Dal 2011 Google è anche, con Google Plus, uno dei social più innovativi e diffusi (per ora, è secondo solo a Facebook), impegnato peraltro in una continua espansione e, come ogni piattaforma, oggetto di amore e di odio in quella sorta di continua disfida tra “guelfi e ghibellini” tipica dei frequentatori della rete (che hanno le loro passioni, i loro tic, le loro diffidenze).
Da quando Google Plus è nato, oltre alla manualistica ufficiale prodotta dalla casa madre californiana, si scrivono e stampano manuali e si offrono veri e propri corsi di formazione, rivolti non solo a chi voglia scoprire le potenzialità di un social diverso da quelli tradizionali, come Facebook, ma anche a chi intenda usare la piattaforma per creare business aziendale: le “cerchie”, infatti, possono diventare appetibili target commerciali. Google Plus è quindi anche un formidabile strumento per chi opera nel web marketing. I suoi algoritmi sono infatti in grado di associare dati personali e di creare relazioni più che virtuali, istillando affinità e preferenze o suggerendo scelte di consumo. E il rischio che un malcapitato utente finisca stritolato è alto. Da qui l’intervento del Garante. Ma la tutela dell’utente passa anche dai buoni manuali e dai buoni formatori. Un buon manuale indipendente o un buon formatore indipendente deve saper mettere in luce le differenze e fornire strumenti critici agli utenti per distinguere. Deve, cioè, far capire che la rete, nonostante gli strumenti democratici di cui dispone (la vigilanza “dal basso” e “dall’alto”), è un perpetuo luogo a rischio di ambiguità, poiché la comunicazione e la socializzazione sono o possono essere contaminati da manipolazioni e da interessi (e non parliamo di quelli legittimi, se trasparenti, degli inserzionisti pubblicitari).
 Il libro che presentiamo, “Scopri Google Plus e conquista il Web” di Salvatore Russo (collana WebBook di Dario Flaccovio Editore, www.darioflaccovio.it), è una dichiarazione d’amore verso le potenzialità di Google Plus, insegna tutto quel che c’è da sapere per destreggiarsi nella piattaforma, ma è pure intelligentemente attraversato da opinioni e contributi che mettono i giusti accenti critici là dove vanno messi. Ma che cos’è in due parole Google Plus? Non è un social network, dicono gli appassionati. Sarebbe come dire che è un altro Facebook. E’ piuttosto un Social Layer, come la stessa public company californiana ama definirlo: cioè uno “strato” di servizi “popolari”, una sorta di gigantesco emporio di servizi e contenuti dentro il quale si incentiva la socializzazione. E’, insomma, una Social Spine, come dice Salvatore Russo, qualcosa di più di un “plug”, una “spina” che attiva l’intero sistema Google; o meglio, una sorta di “spina dorsale” di quel sistema. “Google Plus – scrive Russo – permette di eseguire tutte le attività classiche di un social network (condivisione post, foto, video, link e interazioni con gli utenti) con il valore aggiunto di una sempre più forte integrazione con tutti i servizi Google. E’ la Social Spine che attiva e rafforza l’intero sistema Google, in quanto fortemente connesso con tutti gli altri prodotti della società di Mountain View: motore di ricerca, Maps, Drive, YouTube, Gmail, Chrome, Android, eccetera”.
Il libro che presentiamo, “Scopri Google Plus e conquista il Web” di Salvatore Russo (collana WebBook di Dario Flaccovio Editore, www.darioflaccovio.it), è una dichiarazione d’amore verso le potenzialità di Google Plus, insegna tutto quel che c’è da sapere per destreggiarsi nella piattaforma, ma è pure intelligentemente attraversato da opinioni e contributi che mettono i giusti accenti critici là dove vanno messi. Ma che cos’è in due parole Google Plus? Non è un social network, dicono gli appassionati. Sarebbe come dire che è un altro Facebook. E’ piuttosto un Social Layer, come la stessa public company californiana ama definirlo: cioè uno “strato” di servizi “popolari”, una sorta di gigantesco emporio di servizi e contenuti dentro il quale si incentiva la socializzazione. E’, insomma, una Social Spine, come dice Salvatore Russo, qualcosa di più di un “plug”, una “spina” che attiva l’intero sistema Google; o meglio, una sorta di “spina dorsale” di quel sistema. “Google Plus – scrive Russo – permette di eseguire tutte le attività classiche di un social network (condivisione post, foto, video, link e interazioni con gli utenti) con il valore aggiunto di una sempre più forte integrazione con tutti i servizi Google. E’ la Social Spine che attiva e rafforza l’intero sistema Google, in quanto fortemente connesso con tutti gli altri prodotti della società di Mountain View: motore di ricerca, Maps, Drive, YouTube, Gmail, Chrome, Android, eccetera”.
 Dal manuale di Russo, che è un giovane esperto di web marketing e un consulente aziendale, pubblichiamo il “glossario” di base, utile per chiunque decida di entrare nel mondo di Google+.
Dal manuale di Russo, che è un giovane esperto di web marketing e un consulente aziendale, pubblichiamo il “glossario” di base, utile per chiunque decida di entrare nel mondo di Google+.
di Salvatore Russo
+ 1
E’ il modo più immediato per far sapere che hai apprezzato un contenuto. I tuoi +1 e quelli che riceverai sono importantissimi, perché influenzano i risultati delle ricerche Google. Non devi però esserne ossessionato, altrimenti diventi cieco. Decidi tu in che modo pronunciarlo:
- Più Uno (classico intramontabile)
- Plas Uan (american style)
- Plas Uno (esterofilo pentito)
- Più One (Bim Bum Bam)
Authorship
Google Authorship consente di collegare i tuoi post al tuo profilo Google+, in modo tale da far identificare a Google che tu sei il reale autore di quel contenuto. Perché dovresti farlo? Quando in una ricerca viene visualizzata una pagina contrassegnata tramite l’Authorship, Google potrebbe assegnare ad essa il nome e la fotografia dell’autore (la stessa caricata su Google+).
Author Rank
E’ un indice come il Page Rank, ma invece di assegnare un valore alla pagina web lo assegna al suo autore. Quindi la credibilità e la reputazione dell’autore diventano decisivi ed assume un valore fondamentale l’utilizzo dell’Authorship, che serve appunto per far capire a Google chi è l’autore di un determinato contenuto.
Bounce Rate (tasso di rimbalzo)
Bounce Rate è un termine utilizzato nell’analisi del traffico di un sito web. Un bounce (in inglese rimbalzo) avviene quando l’utente abbandona il sito dopo aver preso visione di una sola pagina web entro pochi secondi. Come cambiano i tempi! Quando ero ragazzo il “Bounce Rate” rappresentava il tasso di rimbalzo del buttafuori all’ingresso della discoteca…
Cerchie
Pensa alle cerchie di Google+ come a delle categorie. Sostanzialmente con le cerchie è possibile classificare i tuoi contatti in base ai tuoi interessi.
Citroll
Assonanza con Citrullo (variante, di origine napoletana, di cetriolo). Persona sciocca, che agisce con poco cervello. A differenza del Troll non compie le sue gesta seguendo maliziosamente un piano premeditato, ma semplicemente usa i social network senza averne capito lo spirito e sputa odio come una lama digitale verso chiunque orbiti nelle sue vicinanze!
CPL (Cost Per Lead)
“Costo per contatto” viene utilizzato per riferirsi alla spesa che fa un inserzionista per ogni contatto generato dalla pubblicità che ha messo online. Praticamente ad ogni utente che si registra su un form specifico, e che quindi lascia informazioni personali rilevanti per l’inserzionista, corrisponde una data somma di denaro.
CPM (Cost Per Mille)
E’ un indicatore comunemente usato nel settore pubblicitario al fine di calcolare il costo di una campagna pubblicitaria in base al numero di visualizzazioni. Ad esempio: ho acquistato banner pubblicitari sul sito X a 5 euro a CPM (5 euro per ogni 1000 visualizzazioni del banner). Alla fine della campagna il banner ha totalizzato 2 milioni di impression, quindi dovrò pagare diecimila euro (2.000.000:1000 = 2000; 2000 x 5 euro = 10.000 euro).
CTR (Click-Through Rate)
In italiano “Percentuale di clic”, è un tasso che misura l’efficacia di una campagna pubblicitaria online o in generale di qualsiasi tua attività online che richiede l’interazione tramite un clic, appunto, da parte dell’utente. Se ad esempio un tuo annuncio Adwords viene visualizzato nella ricerca di Google cento volte (impression) e cliccato 10 volte, il CTR risulterà del 10%. Il CTR misura sostanzialmente l’interesse che riesce a suscitare il tuo contenuto.
Embed
To embed significa incorporare, fare mio. Per ciò che riguarda Internet significa sostanzialmente inserire in un sito un contenuto proveniente da un altro sito, social network, piattaforma, etc.
Engagement
Il coinvolgimento degli utenti è uno degli obiettivi primari dei professionisti del marketing: attirare l’attenzione e coinvolgere la propria community in una sana e proficua conversazione.
#EpicFail
Ogni mattina un responsabile marketing si sveglia e sa che potrebbe essere un giorno buono per un #EpicFail. E’ l’hashtag utilizzato dagli utenti per manifestare il loro disappunto per un determinato post, spot pubblicitario, concorso, etc. In merito ci sono dei casi epici! Se decidi di iniziare a conversare, devi avere un piano strutturato per la gestione delle crisi da #EpicFail.
Fake
Un fake è una performance di un appartenente a una comunità online (social network, chat, form, etc.), che pratica una sorta di “gioco di ruolo” interpretando una personalità che non gli è propria (es. una top model ammiratissima, che nel tempo libero si finge un nerd obeso e psicopatico su Google+).
Fake Inconscio
E’ colui che interpreta se stesso, ma a capocchia! E’ la vera realtà aumentata! Una sovrapposizione di livelli informativi fake della propria vita.
Flame/Flamer
Fiamma in inglese, è un termine utilizzato nel gergo delle comunità virtuali di Internet per identificare un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un altro individuo. Il flamer è colui che appicca questi incendi virtuali; nella vita reale lo puoi riconoscere nelle riunioni condominiali: solitamente sbraita per i millesimali.
Follower
Tutte le persone che ti hanno aggiunto alle loro cerchie.
Google Poseur
Sono tutti coloro che hanno un account su Google+, ma che non hanno ancora capito la differenza tra Google+ e tutti gli altri social network, replicando ciò che facevano già male su Twitter e Facebook. Come riconoscere un Google Poseur:
- I suoi post di solito contengono poche parole, una secchiata di hashtag e un link, ovviamente verso un suo contenuto.
- Pur avendo un botto di follower i suoi post sono privi di commenti e ricondivisioni.
- Non commenta e ricondivide post altrui. Nemmeno un coccoloso +1, niente.
- L’unica forma, malsana, di ricondivisione che apprezza sono le cerchie condivise, con il preciso scopo di aumentare il numero di follower, come se fosse un videogame degli anni Novanta. Le cerchie condivise sono per lui come i #FF (followefriday) il venerdì su Twitter, un modo banale e artificioso di creare movimento intorno a un account di plastica.
GPlussers
Sono gli utenti di Google+, quelli che hanno capito lo spirito di questa piattaforma, in cui lo scambio di informazioni, la collaborazione e la condivisione di idee può trovare la sua massima espressione. Questo è possibile sia per come è stato concepito Google+ che per l’atteggiamento assolutamente positivo di molti professionisti che da subito hanno portato in questo nuovo mondo comunicativo caravelle ricolme di idee, contenuti e soprattutto voglia di condividerle. La community GPlussers ne è per me la massima espressione. Ovviamente dico questo perché la gestisco io!
Hangouts
Strumento di chat e videochiamata di Google+.
Hashtag
Gli hashtag sono oramai presenti in tutti i social network. Cosa sono? L’hashtag è una parola o una frase (senza spazi) preceduta dal simbolo #, ad esempio #GooglePlus, che aiuta le persone a trovare e partecipare a conversazioni riguardanti un determinato argomento. Su Google+ facendo clic sull’hashtag vengono visualizzati i contenuti ad esso correlati. Rappresenta un sistema per aggregare facilmente tutti i contenuti con lo stesso argomento, una sorta di cartelletta digitale.
KPI (Key Performance Indicators)
Rappresenta un obbiettivo aziendale determinato da un valore ben preciso, la vicinanza o meno a tale valore ci dà una chiara valutazione delle nostre performance.
Menzione
Per citare qualcuno nei propri commenti o post basta utilizzare il simbolo + oppure @ seguito dal nome (ad esempio +salvatore russo). La persona menzionata riceverà in automatico una notifica che lo inviterà a partecipare alla discussione.
PageRank
Il PageRank è un valore numerico da 0 a 10 attribuito ad ogni pagina web che è indicizzata sul motore di ricerca Google e che stabilisce il grado di importanza di quella pagina rispetto a tutto lo spettro di documenti indicizzati sul web.
Pagina Google+
Sono gli account Google+ per le aziende. Le pagine Google+ interagiscono nell’ambiente Google+ in modo del tutto simile ai proprietari dei normali profili e consentono quindi di aggiungere persone alle cerchie, modificare il proprio profilo, condividere contenuti, fare +1 su commenti, foto, creare e partecipare agli Hangout.
Plusuanna
Colui che pigia il bottone +1.
PPC (Pay Per Click)
E’ una modalità di acquisto e pagamento della pubblicità online; l’inserzionista paga una tariffa unitaria solo quando un utente clicca effettivamente sull’annuncio pubblicitario. Un esempio di pubblicità Pay Per Click è Google Adwords, cioè annunci sponsorizzati che compaiono nei risultati del motore di ricerca Google.
ROI (Return On Investments)
Tradotto come indice di redditività del capitale investito o ritorno sugli investimenti, indica quanto rende il capitale investito nell’azienda. Indice ovviamente fondamentale nel marketing.
SEM (Search Engine Marketing)
Tutte le attività (comprese quelle SEO) utili a generare traffico qualificato verso un determinato sito web. Lo scopo è portare al sito, tramite i motori di ricerca, il maggior numero di visitatori realmente interessati.
SEO (Search Engine Optimization)
L’insieme di attività finalizzate a migliorare rilevazione, analisi e lettura del sito web da parte dei motori di ricerca, in modo tale da migliorarne potenzialmente il posizionamento nella SERP.
SERP (Search Engine Report Page)
Pagina dei risultati del motore di ricerca. Banalmente, per fare un esempio, se va sui Google o su un altro motore di ricerca e digiti “orecchiette con le cime di rapa” i risultati che riceverai (generalmente elencati a pagine di 10) rappresentano la SERP.
Short Link
Una delle pratiche più comuni e utilizzate quando si condividono i propri post è quella di accorciare gli URL. Per farlo è possibile utilizzare uno dei tanti servizi gratuiti (io ne consiglio due su tutti: bit.ly e goo.gl).
Smarmellare
Il lato buono dello Spam. E’ la condivisione di buoni contenuti, con l’intento di raggiungere l’intera popolazione di Internet. Per farlo è necessario tutto l’amore dei propri follower. E per farsi amare dai propri follower è necessaria la nostra più totale dedizione a un unico obbiettivo: la buona conversazione.
Social Cosi
Tutti coloro che a vario titolo lavorano su social media, comunità virtuale e accrocchi 2.0 allo scopo di generare visibilità verso un determinato brand. Questo “soprannome” quindi racchiude una moltitudine di professioni anche molto differenti tra loro, ma accomunate dal media utilizzato per veicolare la propria comunicazione. Essendoci in Italia ancora una forte digital divide, il termine “coso” prende il posto di Social Media Strategist, Social Media Management, Social… Coso.
Social Eroi
Possiamo trovare nel nostro vivere quotidiano degli esempi di uomini dotati di poteri fuori dal comune? Non lo so, ma l’idea mi è sempre piaciuta. Ed è proprio grazie a quest’idea, al mio lavoro e alle mie passioni che ho potuto conoscere alcune persone con un peculiare e marcato talento, capaci di utilizzare i network sociali per “fare del bene” e farlo in svariati modi, due su tutti: mettono a disposizione le loro abilità professionali condividendo pensieri, idee, contenuti qualitativamente alti che incoraggiano discussioni costruttive; producono sorrisi grazie alla loro naturale simpatia e ironica. Questi sono i #SocialEroi.
Spam
Il Male. Il termine ha origine da una scena della serie tv inglese “Monty Python Flying Circus” (roba di 43 anni fa) in cui si prendeva in giro la carne in scatola “Spam” presente ovunque in Gran Bretagna negli anni del dopoguerra, sia sulle tavole che in pubblicità. Ora viene utilizzato per definire i messaggi e-mail non richiesti, di solito utilizzati a scopo commerciale o pubblicitario. Io estendo il concetto a tutte le attività pubblicitarie poco trasparenti, non richieste, massive, cheap, aggressive, tipo “scade domenica”.
Stream
Sostanzialmente il flusso delle informazioni visualizzate in una determinata piattaforma. Ad esempio il giovane che esclama “ho visto il tuo post nello stream home di G+”, ti sta semplicemente dicendo che ha visualizzato il tuo post nella schermata principale del suo account Google+, tranquillo.
Temi Caldi
Argomenti di maggior successo in Google+, è possibile trovarli sparsi nel tuo stream oppure raccolti ordinati e pettinati all’interno dell’apposita sezione, appunto Temi Caldi raggiungibile tramite il menu di sinistra nel tuo account Google+.
Troll
Colui il quale dedica la propria attività online a distruggere una determinata comunità virtuale, attraverso un sistematico uso di messaggi provocatori e violazioni della “netiquette”.


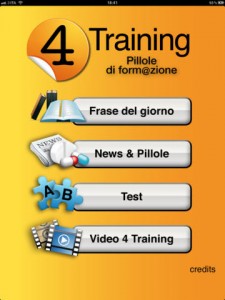 Lo abbiamo chiesto al Gruppo Varvelli, il gruppo che, con base a Torino, è specializzato da decenni nella ricerca applicata al management e nella diretta formazione dei manager (preziosi i loro corsi e i loro manuali pubblicati per le edizioni de “Il Sole 24 Ore”), e che di recente ha anche messo a punto una App chiamata “4 Training”, una sorta di “integratore energetico (così la definiscono) di consigli, ricette, frasi, citazioni, video e test per costruire la propria personale strada verso il successo e il potenziamento delle proprie capacità”.
Lo abbiamo chiesto al Gruppo Varvelli, il gruppo che, con base a Torino, è specializzato da decenni nella ricerca applicata al management e nella diretta formazione dei manager (preziosi i loro corsi e i loro manuali pubblicati per le edizioni de “Il Sole 24 Ore”), e che di recente ha anche messo a punto una App chiamata “4 Training”, una sorta di “integratore energetico (così la definiscono) di consigli, ricette, frasi, citazioni, video e test per costruire la propria personale strada verso il successo e il potenziamento delle proprie capacità”.  In Italia è un’estate calda per Google. Il Garante della Privacy ha dato 18 mesi di tempo al gigante di Mountain View per rendere chiare e inequivocabili tutte le informative agli utenti. Chi accede ai vari servizi di Google deve sapere se il proprio profilo viene sfruttato a fini commerciali. In questo caso, l’utente deve dare un esplicito consenso e non finire a sua insaputa nella grande marmellata virtuale, in quel miscuglio in cui con un clic si diventa un “dato” buono per una molteplicità di piattaforme e per gli usi più disparati. Diventano più stringenti anche gli obblighi per la cancellazione degli account o dei dati personali, se un utente vuole recedere. Google si è detta pronta a collaborare e, in genere, una compagnia di quelle dimensioni mantiene la parola.
In Italia è un’estate calda per Google. Il Garante della Privacy ha dato 18 mesi di tempo al gigante di Mountain View per rendere chiare e inequivocabili tutte le informative agli utenti. Chi accede ai vari servizi di Google deve sapere se il proprio profilo viene sfruttato a fini commerciali. In questo caso, l’utente deve dare un esplicito consenso e non finire a sua insaputa nella grande marmellata virtuale, in quel miscuglio in cui con un clic si diventa un “dato” buono per una molteplicità di piattaforme e per gli usi più disparati. Diventano più stringenti anche gli obblighi per la cancellazione degli account o dei dati personali, se un utente vuole recedere. Google si è detta pronta a collaborare e, in genere, una compagnia di quelle dimensioni mantiene la parola. Il libro che presentiamo, “Scopri Google Plus e conquista il Web” di Salvatore Russo (collana WebBook di Dario Flaccovio Editore,
Il libro che presentiamo, “Scopri Google Plus e conquista il Web” di Salvatore Russo (collana WebBook di Dario Flaccovio Editore,  Dal manuale di Russo, che è un giovane esperto di web marketing e un consulente aziendale, pubblichiamo il “glossario” di base, utile per chiunque decida di entrare nel mondo di Google+.
Dal manuale di Russo, che è un giovane esperto di web marketing e un consulente aziendale, pubblichiamo il “glossario” di base, utile per chiunque decida di entrare nel mondo di Google+. Cecilia Andrea Bacci e Alessandra Borella
Cecilia Andrea Bacci e Alessandra Borella Madre Sara, la badessa del monastero di Sant’Agnese
Madre Sara, la badessa del monastero di Sant’Agnese L’ingresso del monastero
L’ingresso del monastero

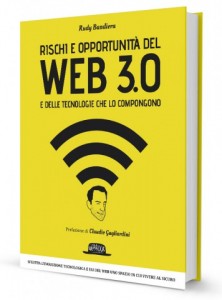

 Ogni volta che si spara a un giornalista il racconto di un pezzo di mondo scompare. Andy Rocchelli, il fotoreporter piacentino di 30 anni ucciso la notte del 24 maggio in Ucraina, stava lavorando a una storia: le cantine usate come bunker dalla popolazione civile. Se non ci fosse stato lui nessuno di noi avrebbe visto quelle immagini di bambini raccolti in silenzio nel buio di uno scantinato. Nessuno conoscerebbe quella storia. Ma il suo racconto è stato bruscamente interrotto.
Ogni volta che si spara a un giornalista il racconto di un pezzo di mondo scompare. Andy Rocchelli, il fotoreporter piacentino di 30 anni ucciso la notte del 24 maggio in Ucraina, stava lavorando a una storia: le cantine usate come bunker dalla popolazione civile. Se non ci fosse stato lui nessuno di noi avrebbe visto quelle immagini di bambini raccolti in silenzio nel buio di uno scantinato. Nessuno conoscerebbe quella storia. Ma il suo racconto è stato bruscamente interrotto.




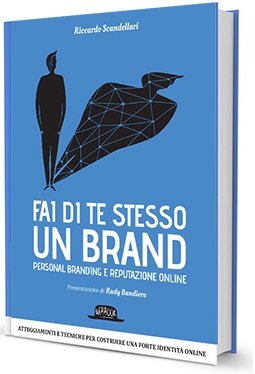 La rete non è soltanto uno sconfinato territorio di ricerca di informazioni o di socializzazione. Per tanti è anche uno strumento di lavoro. Ma se sei nella rete, e vuoi socializzare, condividere, dire la tua o vendere un prodotto (editoriale e no), deve farti riconoscere: devi costruirti un Personal Branding. Insomma, devi diventare (e i puritani storceranno il naso) una “marca”. “Fai di te stesso un brand” di Riccardo Scandellari è un libro che si occupa di questo: anzi è un vero e proprio manuale, una miniera di grandi e piccole istruzioni, per “costruire una forte identità online”. Pubblicato da Dario Flaccovio Editore (www.darioflaccovio.it), il testo non scende negli aspetti tecnici (ci sono tanti libri che spiegano come configurare una pagina Facebook o Twitter o come aprire un blog) ma illustra quello che avviene dopo: spiega cioè come sfruttare le potenzialità dei maggiori social network per affermare la propria identità online, insegna a utilizzare al meglio il proprio blog per “creare un’immagine chiara e coerente” e “mettere le basi per crearsi un seguito e amministrarlo”. L’autore, il ferrarese Roberto Scandellari, giornalista e creativo (il suo sito è www.skande.com) si occupa di web dal 1998, e con Rudy Bandiera (che ha curato la prefazione del libro) ha fondato l’agenzia NetPropaganda. Da “Fai di te stesso un brand” pubblichiamo alcune preziose “istruzioni” di base.
La rete non è soltanto uno sconfinato territorio di ricerca di informazioni o di socializzazione. Per tanti è anche uno strumento di lavoro. Ma se sei nella rete, e vuoi socializzare, condividere, dire la tua o vendere un prodotto (editoriale e no), deve farti riconoscere: devi costruirti un Personal Branding. Insomma, devi diventare (e i puritani storceranno il naso) una “marca”. “Fai di te stesso un brand” di Riccardo Scandellari è un libro che si occupa di questo: anzi è un vero e proprio manuale, una miniera di grandi e piccole istruzioni, per “costruire una forte identità online”. Pubblicato da Dario Flaccovio Editore (www.darioflaccovio.it), il testo non scende negli aspetti tecnici (ci sono tanti libri che spiegano come configurare una pagina Facebook o Twitter o come aprire un blog) ma illustra quello che avviene dopo: spiega cioè come sfruttare le potenzialità dei maggiori social network per affermare la propria identità online, insegna a utilizzare al meglio il proprio blog per “creare un’immagine chiara e coerente” e “mettere le basi per crearsi un seguito e amministrarlo”. L’autore, il ferrarese Roberto Scandellari, giornalista e creativo (il suo sito è www.skande.com) si occupa di web dal 1998, e con Rudy Bandiera (che ha curato la prefazione del libro) ha fondato l’agenzia NetPropaganda. Da “Fai di te stesso un brand” pubblichiamo alcune preziose “istruzioni” di base. C’è una ricetta per la visibilità online. Semplificando al massimo, gli ingredienti base sono due: identità (personale o aziendale) e contenuto. L’identità è definita come Brand Identity se sei un’azienda o Personal Branding se sei una persona: è un fattore da studiare e non lasciare al caso perché potresti rendere meno efficaci i contenuti di qualità che andrai a creare.
C’è una ricetta per la visibilità online. Semplificando al massimo, gli ingredienti base sono due: identità (personale o aziendale) e contenuto. L’identità è definita come Brand Identity se sei un’azienda o Personal Branding se sei una persona: è un fattore da studiare e non lasciare al caso perché potresti rendere meno efficaci i contenuti di qualità che andrai a creare.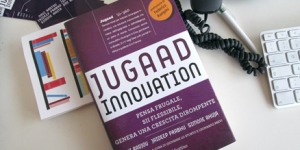 Esce in Italia “Jugaad Innovation”, pubblicato da Rubettino. Un libro rivoluzionario, che ha avuto un enorme successo all’estero. Jugaad è una parola che in hindi descrive un processo di innovazione che proviene dal basso ed è in grado di creare soluzioni efficienti a costi contenuti, una vera e propria “rivoluzione culturale” che sfida i modelli di produzione dell’Occidente.
Esce in Italia “Jugaad Innovation”, pubblicato da Rubettino. Un libro rivoluzionario, che ha avuto un enorme successo all’estero. Jugaad è una parola che in hindi descrive un processo di innovazione che proviene dal basso ed è in grado di creare soluzioni efficienti a costi contenuti, una vera e propria “rivoluzione culturale” che sfida i modelli di produzione dell’Occidente.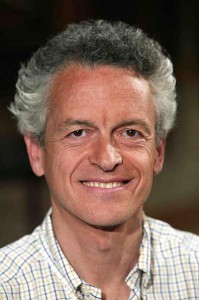 La prima volta che mi sono imbattuto in una innovazione Jugaad, questa aveva l’aspetto dimesso di un elettrodomestico low cost. Per la precisione una lavatrice da cinquanta euro, della marca Videocon. Un apparecchio plebiscitato dalle massaie indiane non solo per il basso costo, ma per un altro aspetto che lo rende prezioso: una speciale memoria elettronica programmata per neutralizzare i blackout elettrici, e consentire al programma di lavaggio di riprendere indisturbato là dove si era interrotto, non appena la corrente torna (magari molte ore dopo). È un esempio emblematico.
La prima volta che mi sono imbattuto in una innovazione Jugaad, questa aveva l’aspetto dimesso di un elettrodomestico low cost. Per la precisione una lavatrice da cinquanta euro, della marca Videocon. Un apparecchio plebiscitato dalle massaie indiane non solo per il basso costo, ma per un altro aspetto che lo rende prezioso: una speciale memoria elettronica programmata per neutralizzare i blackout elettrici, e consentire al programma di lavaggio di riprendere indisturbato là dove si era interrotto, non appena la corrente torna (magari molte ore dopo). È un esempio emblematico. I tre autori cominciarono a studiare il modello indiano e quello di altre nazioni emergenti tanti anni fa, in cerca di quella strategia alternativa all’innovazione. Un conto è fare ricerca e sviluppo in un laboratorio modernissimo, ricco di fondi, nella Silicon Valley. Altro è tentare di innovare in mezzo al caos, all’imprevedibilità di una società emergente come quella indiana, o brasiliana. E tuttavia alcune delle innovazioni nate in quei contesti hanno avuto una diffusione vastissima e rapida: perché le nuove tecnologie digitali hanno abbattuto barriere e distanze, consentendo all’idea vincente di viaggiare con la velocità della luce. La soluzione che si adatta ai bisogni della massaia indiana è la stessa che può conquistare istantaneamente centinaia di milioni di consumatrici africane. L’innovazione Jugaad nasce da un rovesciamento di approccio: la scarsità di risorse, gli ostacoli economici, la mancanza di infrastrutture, la burocrazia inefficiente, si trasformano in opportunità perché diventano altrettanti stimoli. Le soluzioni Jugaad sono prodotti o servizi semplici, essenziali. I consumatori meno abbienti non sono più visti come un mercato minore, o addirittura come popolazioni da aiutare con sussidi e carità, al contrario diventano un motore di sviluppo.
I tre autori cominciarono a studiare il modello indiano e quello di altre nazioni emergenti tanti anni fa, in cerca di quella strategia alternativa all’innovazione. Un conto è fare ricerca e sviluppo in un laboratorio modernissimo, ricco di fondi, nella Silicon Valley. Altro è tentare di innovare in mezzo al caos, all’imprevedibilità di una società emergente come quella indiana, o brasiliana. E tuttavia alcune delle innovazioni nate in quei contesti hanno avuto una diffusione vastissima e rapida: perché le nuove tecnologie digitali hanno abbattuto barriere e distanze, consentendo all’idea vincente di viaggiare con la velocità della luce. La soluzione che si adatta ai bisogni della massaia indiana è la stessa che può conquistare istantaneamente centinaia di milioni di consumatrici africane. L’innovazione Jugaad nasce da un rovesciamento di approccio: la scarsità di risorse, gli ostacoli economici, la mancanza di infrastrutture, la burocrazia inefficiente, si trasformano in opportunità perché diventano altrettanti stimoli. Le soluzioni Jugaad sono prodotti o servizi semplici, essenziali. I consumatori meno abbienti non sono più visti come un mercato minore, o addirittura come popolazioni da aiutare con sussidi e carità, al contrario diventano un motore di sviluppo.