Oltre la grata: così abbiamo incontrato la clausura, ai tempi di internet
 Cecilia Andrea Bacci e Alessandra Borella
Cecilia Andrea Bacci e Alessandra Borella
“Servizio ben realizzato, interessante e per certi versi sorprendente. Costruito su un’idea, con un taglio particolare e una cura insolita, ci offre le immagini inedite di donne che hanno fatto una scelta di vita diversa”.
E’ la motivazione della giuria della Settima Edizione del Premio dedicato alla memoria e all’impegno giornalistico di Gaspare Barbiellini Amidei vinto (nella sezione tv e radio) da Cecilia Andrea Bacci e Alessandra Borella, per il servizio video “Oltre la grata, la clausura al mondo d’oggi”, trasmesso il 21 marzo 2014 su Quattro Colonne SGRT News – testata della Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia.
Il Premio, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è rivolto ai giovani impegnati nella professione (sotto i 35 anni) per incoraggiare un giornalismo libero, innovativo e di qualità.
Il tema della Settima Edizione era: “Verde, Bianco e ROSA? L’Italia delle donne”. Dacia Maraini è stato Giurato speciale per l’Edizione 2014.
di Alessandra Borella e Cecilia Andrea Bacci
È dicembre. Seduta dietro la grata, il velo le nasconde la testa, i capelli, le orecchie. Quello che colpisce all’istante osservando il suo volto incorniciato, è la pelle rosea e luminosa che non ne tradisce l’età. Sembra una ragazza di vent’anni. Slanciata, bella. È una donna che ne ha compiuti quaranta pochi giorni fa. Si chiama Sara. Non un filo di trucco, i suoi occhi sono dolcissimi. È la Madre Abbadessa del convento.
 Madre Sara, la badessa del monastero di Sant’Agnese
Madre Sara, la badessa del monastero di Sant’Agnese
È lei che deciderà se farci entrare. Io e Cecilia abbiamo deciso di raccontare la clausura. Sarà il tema del nostro reportage. Questa curiosità, così lontana dalla nostra vita personale e professionale, ci trova in sintonia. Molte telefonate, un solo “sì” ad accordarci un appuntamento di persona. Quello del monastero delle clarisse di Sant’Agnese, nel centro storico di Perugia. Si trova in corso Garibaldi, dove ci sono tre conventi in 200 metri: clarisse, benedettine e domenicane.
Quello delle clarisse è noto alla comunità anche perché custodisce un prezioso dipinto del Perugino, la “Madonna delle Grazie con santi”, conosciuto come “Madonna Immacolata” negli archivi del monastero.
Papa Leone XIII concesse una dispensa dalla clausura, nella zona che va dall’esterno al corridoio che porta dentro la cappella di sant’Agnese, dov’è custodito il Perugino. Le monache riebbero il monastero dal demanio in cambio dell’impegno a fare da guide a chi volesse visitare il quadro. Ed è tuttora così, dal primo decennio del Novecento.
 L’ingresso del monastero
L’ingresso del monastero
Salendo la stradina che porta alla piazzetta dove sorge il palazzo, si respira un’atmosfera mistica. Sarà per il silenzio straniante, cui non siamo abituate. Un’oasi di pace, nel cuore della città.
La prima volta che entriamo nel refettorio, non è Sara ad accoglierci. La luce filtra fioca da una sola finestra. Si gela. I minuti di attesa sono interminabili. Una luce si accende, un rumore sottile di passi si avvicina. Entra Mariachiara. È minuta, eppure sprigiona una forza che invade la stanza. Incute timore. È la prima suora di clausura che vediamo. Finora, ne avevamo solo sentito parlare. Ci stringe le mani, gesto che faranno tutte, sempre. Ci invita ad accomodarci, siamo tese. Due ore di colloquio. Ci scruta, dietro le lenti spesse degli occhiali. Ci interroga sul progetto, con una placida ma autorevole solennità.
In quei momenti non ci saremmo mai immaginate che proprio Mariachiara ci avrebbe guidato all’interno, con i suoi passetti rapidi e scattanti, costringendoci ad un inseguimento serrato con le telecamere e i fili del microfono, che dalla sua veste alle nostre mani si incastrano ovunque. Reggerà il cavalletto, raccontando senza sosta la storia di quei luoghi, come una vera “producer”, così come l’abbiamo ribattezzata scherzosamente in seguito. È stata lei la nostra prima sostenitrice. Ci ha dato fiducia ed è bastato un suo sguardo primaverile e materno, dietro la grata, con il montaggio finale mostrato loro in anteprima sul nostro computer, per capire che non avevamo fallito nel desiderio di raccontarle fedelmente, senza tradirne lo spirito, senza violarne l’intimità.
In un mese di post-produzione, decine di ore di girato erano lì, davanti ai loro occhi, racchiuse in otto minuti. Mariachiara, Sara e poi Speranza e Agnese. Sono quattro delle quindici sorelle clarisse che ci hanno aperto le porte del monastero in cui vivono. Speranza è perugina, ha una laurea in scienze politiche. Ironizza sulla sua vocazione e il suo viso esplode in risate spontanee e contagiose. Agnese è calabrese, ha studiato legge. Quando risuona una voce squillante al di là delle pareti, è lei che ne sta combinando una delle sue. Si occupano dei ritiri spirituali nei quali ospitano i giovani (io e Cecilia comprese), curano il sito internet e rispondono assiduamente alle email.

Sono seguiti numerosi colloqui dopo il primo con suor Mariachiara. Qualche messa e gli inviti ad assistere ai vespri (la preghiera della sera) e alle adorazioni eucaristiche. Alcuni accettati: né io, né Cecilia, abbiamo avuto timore di rimettere piede in una chiesa. Non avremmo potuto capire appieno la clausura senza partecipare, almeno in parte, al tempo delle preghiere, che scandisce la loro giornata. Non conta condividerle o recitarle.
Dentro la chiesetta adiacente al monastero, potevamo scorgere le nostre “ragazze”, dalla finestrella con la grata che si trova dietro l’altare: erano sedute sulle panche in legno del coro, dall’altra parte del muro. Avrei giurato di scorgere, più di qualche volta, malcelati sorrisi rivolti a me e Cecilia, sedute sui banchi con espressione seriosa (o, piuttosto, malcelata rassegnazione). Passano l’avvento e il Natale.
Solo a metà gennaio riceviamo la telefonata tanto attesa. “Vi faremo raccontare le nostre storie. Potrete entrare con la telecamera”. Il nostro progetto prende forma. Tutto ciò che è accaduto poi, lo raccontano le nostre immagini. Quasi tutto. Non raccontano l’abbraccio che ci ha unito, la prima volta che si è aperto il portone e ci siamo viste tutte quante, una di fronte all’altra, senza grata. O lo stupore quando ci siamo accorte dei loro piedi nudi dentro i sandali, in pieno inverno. O le risate fragorose, l’ironia, le prese in giro, quando io e Cecilia, incaponite su questioni tecniche, costringevamo le ignare e docili sorelle, di volta in volta soggetti dell’inquadratura, a estenuanti prove e rifacimenti.
Le immagini non raccontano le ore trascorse in loro compagnia, che non si contano. Il profumo delle pietanze in cucina, la polvere sulle pagine dei libri antichi, in biblioteca. Otto minuti sono giorni e giorni, sono ritagli di tempo, tra un vespro e l’altro, per loro, tra una lezione e l’altra, per noi. Sono le domeniche di febbraio. Sono ogni momento utile. Sono pranzi, sorrisi, racconti, confidenze. Sono ore di interviste a tu per tu.
Non ci siamo risparmiate domande scomode: volevamo raccontare la vita claustrale senza pregiudizi e senza indulgenze, dal loro rapporto con il corpo, alla maternità, all’amore. Da donne a donne.

Non sapremo mai come vivono le altre settemila suore di clausura in Italia, ognuna con il suo ordine monastico, con le sue regole e la sua più o meno stretta osservanza. Abbiamo raccontato le storie di quattro monache, stralci della loro esistenza quotidiana, discreta e custodita con grazia. Non leggono i giornali, ma si concedono qualche film, proiettato su un lenzuolo bianco, nel salone sotterraneo che somiglia ad una grande taverna.
Quello che fanno per la comunità va oltre la preghiera; vivono di carità, ma non lesinano aiuto concreto, materiale e spirituale, ai bisognosi, che sia un piatto di pasta, o una parola di conforto. La loro scelta di fede resta incomprensibile alla ragione. Ma non si può restare insensibili dinanzi alla profondità di un incontro umano.
Oltre il mestiere, che ci ha portato a documentarlo, e oltre la grata, che le separa da noi, ma solo fisicamente. Dietro quella grata ci siamo io e Cecilia, inquadrate dall’interno della clausura all’inizio del nostro reportage. Siamo noi, nel mondo che spesso diventa una prigione a cielo aperto, ad essere indagate e interrogate da loro, rinchiuse e libere al tempo stesso. Credenti o no, la serenità che abita quel luogo, quei corpi e quelle menti, entra sotto la pelle. La si vive mettendo piede nella casa di Sara, Mariachiara, Speranza e Agnese. E’ calore. Il calore dell’accoglienza e dell’amicizia. Questo, no, le immagini non possono proprio raccontarlo.

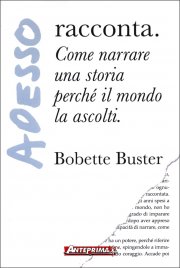







 I politici sono sulle prime pagine dei principali settimanali di gossip, dei rotocalchi e delle riviste di attualità e costume con la stessa frequenza delle celebrità del mondo dello spettacolo. Le riviste patinate sono oggi uno degli strumenti preferenziali attraverso cui informazioni e pettegolezzi (pseudo)privati riguardanti la vita dei politici arrivano a un pubblico che molto spesso è lontano dalla politica, o, comunque, poco avvezzo a seguire l’evolversi del dibattito pubblico. Crozza-Berlusconi lo disse: “Tutti che mi criticano, il Wall Street Journal, il Financial Times, ma chi li legge? Sono in inglese! Quante copie vende Chi e quante il Financial Times? Coglioni!” (da Ballarò del 5 febbraio 2013).
I politici sono sulle prime pagine dei principali settimanali di gossip, dei rotocalchi e delle riviste di attualità e costume con la stessa frequenza delle celebrità del mondo dello spettacolo. Le riviste patinate sono oggi uno degli strumenti preferenziali attraverso cui informazioni e pettegolezzi (pseudo)privati riguardanti la vita dei politici arrivano a un pubblico che molto spesso è lontano dalla politica, o, comunque, poco avvezzo a seguire l’evolversi del dibattito pubblico. Crozza-Berlusconi lo disse: “Tutti che mi criticano, il Wall Street Journal, il Financial Times, ma chi li legge? Sono in inglese! Quante copie vende Chi e quante il Financial Times? Coglioni!” (da Ballarò del 5 febbraio 2013).






 Ogni volta che si spara a un giornalista il racconto di un pezzo di mondo scompare. Andy Rocchelli, il fotoreporter piacentino di 30 anni ucciso la notte del 24 maggio in Ucraina, stava lavorando a una storia: le cantine usate come bunker dalla popolazione civile. Se non ci fosse stato lui nessuno di noi avrebbe visto quelle immagini di bambini raccolti in silenzio nel buio di uno scantinato. Nessuno conoscerebbe quella storia. Ma il suo racconto è stato bruscamente interrotto.
Ogni volta che si spara a un giornalista il racconto di un pezzo di mondo scompare. Andy Rocchelli, il fotoreporter piacentino di 30 anni ucciso la notte del 24 maggio in Ucraina, stava lavorando a una storia: le cantine usate come bunker dalla popolazione civile. Se non ci fosse stato lui nessuno di noi avrebbe visto quelle immagini di bambini raccolti in silenzio nel buio di uno scantinato. Nessuno conoscerebbe quella storia. Ma il suo racconto è stato bruscamente interrotto.










